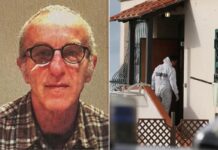MANTOVA Come sempre è la totale immersione in un’altra epoca l’esperienza ispirata dal tour presso Palazzo d’Arco, una visita che avrebbe prossimamente dovuto coinvolgere il pubblico in due date, per scoprire un’altra parte del complesso dei beni del Museo, in questo caso quella legata ai tessuti. Iniziativa che per il momento posso raccontare attraverso queste pagine, ma che certamente si concretizzerà non appena i tempi lo renderanno possibile, anche perché il lavoro e lo studio a sostegno del progetto sono, come sempre, ingenti.
Il viaggio tra le stanze del d’Arco permette di conoscere più a fondo le preziose stoffe che si trovano nella struttura e che di solito vengono ammirate per bellezza e ricchezza, senza però sapere quale meraviglioso mondo si celi tra le loro trame, orditi e lavorazioni. Una realtà svelata grazie al lavoro delle restauratrici Stellina Cherubini e Annalisa Biselli, di R.T. Restauro Tessile di Albinea di Reggio Emilia, che mi hanno illustrato il percorso, svelando i segreti dei prestigiosi manufatti, che spaziano dal tardo Seicento al pieno Ottocento.
Il primo particolare che si nota nell’ambito della visita è quanto e come i tessuti venissero riutilizzati, pure presso famiglie aristocratiche, passando attraverso diversi utilizzi: dall’abito femminile, al paramento sacro o complemento d’arredo. Ciò non solo per un concetto che oggi chiameremmo di riciclo o sostenibilità, ma per poter sfruttare al massimo il valore di merce dalla sublime fattura e sottolinearne il pregio.
Nella sala da pranzo, ad esempio, si può notare una coperta da tavolo, confezionata con un tessuto ottocentesco pensato per uso liturgico, per i motivi decorativi scelti che richiamano i simboli cristologici. Infatti lo stesso tessuto si ritrova in ciò che rimane di una stola conservata a Palazzo. Le sedie sono invece rivestite con tessuti di primo Settecento tipicamente per abiti femminili e si ritrovano impiegati anche in alcuni paramenti sacri sempre conservati nel palazzo. Le sedie della stanza accanto in seta rigata sono invece in apparenza semplici, ma nascondono accortezze tecniche quali lo chinè al la branche. Lo Chiné à la branche, detto anche all’italiana “cinzato” o fiammato per la forma dei motivi decorativi che si ottengono con questa tecnica, simili appunto a fiammature verticali, è realizzato attraverso un procedimento di tintura per riserva simile al moderno batik, e assimilabile come effetto all’ Ikat indiano, che ha origine molto antica. Si ottiene con la tintura di piccoli gruppi di fili di ordito, che vengono legati prima di essere immersi nel bagno di tintura: la legatura impedisce al colore di raggiungere i fili coperti, colorando solo la parte non legata. L’ordito viene poi montato sul telaio e si procede alla tessitura con un filo di trama di un solo colore, di solito bianca/avorio. Per i piccoli spostamenti che subiscono i fili nell’arrotolamento e legatura dell’ordito ne risultano disegni con un effetto sfumato in senso verticale, con contorni imprecisi. Questa tecnica veniva impiegata sia nei tessuti per abbigliamento civile che nell’arredamento (tappezzerie e rivestimenti di mobili, sedie, poltrone ecc…) perché di grande impatto. Nei secoli lo chiné è stato utilizzato e imitato, anche nel ricamo attraverso punti che simulano lo stesso effetto decorativo (punto fiamma, punto ungaro). Le armature di base per lo chiné sono semplici: taffetas e derivati o raso (e per questa scelta esiste una ragione pratica legata alle caratteristiche di queste armature). I due esempi di chiné a Palazzo d’Arco sono entrambi con armatura raso, sia il salottino che la pianeta, esiste anche un’imitazione dello chiné a ricamo nel salottino dove è allestita l’esposizione di cappelli e piume.
Potente anche l’effetto del restauro nella Sala Rossa, dove si è proceduto anche al recupero delle pareti, rivestite in damasco cremisi settecentesco di manifattura inglese. Una chicca, per la prima volta aperta al pubblico, è la Madonna Vestita nella cappella della dimora. Arrivata al Museo dall’abitazione dei d’Arco in via Fernelli, la statua è vestita di damasco broccato di seta, mentre sono in fibre naturali i tessuti sotto il vestimento. I capelli della scultura si compongono di fili di seta. Tali abiti e i reliquiari nella cappella non sono ancora stati restaurati, potrebbero quindi essere oggetto di recupero prossimamente, o almeno questo si auspica.
La statua rappresenta probabilmente un ex voto, poiché indossa un braccialetto nel quale è infilato un cartiglio. La scultura è particolarmente legata anche ad usanze antiche: il rito di vestizione delle statue della Madonna da sempre è una pratica esclusivamente femminile, riservata alle donne devote delle parrocchie.
Dal 2016, anno di riapertura del Museo d’Arco, tanti sono i manufatti restaurati: dai tappeti, alla Sala Rossa, alle stoffe di copertura delle portantine. Ed è significativo scoprire altri tesori del luogo grazie alle conoscenze di chi si sia direttamente occupata del recupero del patrimonio. Una esperienza che io ho naturalmente vissuto in giorni nei quali ancora ciò era permesso. E che aspetta di spalancare le porte a nuovi meravigliati spettatori.
Ilaria Perfetti